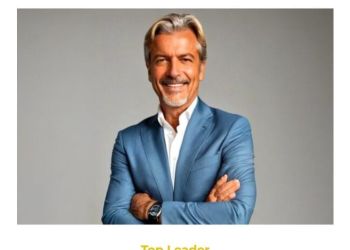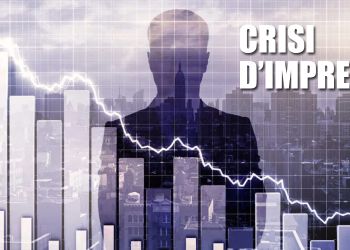D. LGS N. 14/2019 – CRISI E INSOVENZA GLI SCENARI POST LOCKDOWND.
L’argomento “crisi d’impresa” è quanto di più attuale si possa discutere tra gli operatori che quotidianamente affrontano le molteplici problematiche del mondo imprenditoriale.
Già negli ultimi anni si era sentita l’esigenza di introdurre nel nostro ordinamento giuridico, un’adeguata normativa utile non solo alla gestione della fase del dissesto finale, ma anche alla prevenzione di eventuali situazioni di crisi, alla loro individuazione tempestiva e alla successiva gestione con l’obiettivo del risanamento.
Ciò ha portato all’emanazione del D. Lgs n. 14/2019 denominato “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), un articolato normativo di rilievo che ha revisionato completamente la materia, con l’intenzione del legislatore di disciplinare un fenomeno che non si manifesta solo nel mondo dell’imprenditoria per creare dunque, un assetto normativo di base applicabile, seppur con distinte differenziazioni, a qualsiasi situazione di crisi o d’insolvenza possa manifestarsi nei confronti degli imprenditori di qualunque dimensione, dei professionisti e dei debitori in genere.
Il codice stesso all’art. 2 fornisce nuove definizioni per meglio individuare cosa debba intendersi per:
– Crisi: stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che nell’impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
– Insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
– Sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Ovviamente, ciò che in questa sede si intende approfondire è l’impatto che tale rivoluzione normativa provocherà nel mondo imprenditoriale soprattutto alla luce delle previsioni di natura economica legate all’emergenza sanitaria e al conseguente lockdown ancora in corso.
L’entrata in vigore definitiva dell’intero Codice, per la parte relativa alla disciplina e al regolamento degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è stata fissata in 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo ed è prevista per il 15 agosto 2020. La ratio alla base di tale disposizione è legata alla necessità di consentire a tutti i soggetti coinvolti il giusto intervallo temporale per adottare le necessarie misure organizzative e permettere agli operatori specializzati il completamento della giusta formazione.
Tuttavia, in uno scenario in cui i doverosi provvedimenti restrittivi necessari al contenimento della pandemia hanno conseguentemente provocato la chiusura temporanea di tutte quelle attività economiche ritenute NON essenziali, non essendo oggi nelle condizioni di poter ipotizzare quando e come tali provvedimenti saranno revocati, è facile immaginare che nei mesi a venire, e quindi in coincidenza dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, una vasta platea di imprese, soprattutto di medie e piccole dimensioni, potranno rappresentare problemi di liquidità tali da generare squilibri finanziari e renderle insolventi provocando, conseguentemente un nefasto effetto domino sull’intero sistema economico.
Il sistema delle regole introdotte dal Codice della Crisi individua una serie di livelli ad intensità crescente in cui si possono manifestare i diversi gradi di difficoltà dell’impresa e ai quali corrispondono differenti doveri in capo agli organi sociali e/o di controllo:
1) LA PERDITA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE concetto di importanza primaria ma che non rappresenta nulla di nuovo in quanto insito storicamente nell’art. 2423 bis C.C.: ”la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività” e ribadito dal principio contabile OIC 11 in base al quale la direzione aziendale deve effettuare le valutazioni prospettiche della capacità aziendale di “continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.” Il concetto di continuità aziendale inoltre è alla base del Principio di Revisione Isa Italia 570 nel quale è possibile individuare una serie di indicatori, sia di natura economico-finanziaria, sia di natura più generale che possono far emergere dubbi sulla persistenza di tale requisito.
2) LA CRISI intesa come incapacità dei flussi di cassa attuali e prospettici di far fronte all’adempimento delle obbligazioni assunte nell’ordinaria pianificazione gestionale. Viene definita anche la nozione di “indicatori della crisi” (Art. 13 co.1) intesi come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale del debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive della continuità aziendale per l’esercizio in corso.
3) L’INSOLVENZA intesa come stato del debitore di non riuscire più a far fronte alle obbligazioni assunte a causa degli squilibri evidenziati mediante l’applicazione degli indicatori della crisi nei confronti dei quali non sono state applicate le dovute misure correttive.
A ciascuna fase corrispondono obblighi differenziati in capo agli organi societari e a quelli di controllo.
Il codice della Crisi ha introdotto il dovere di un monitoraggio continuo in capo agli amministratori i quali devono dotarsi un assetto adeguato al fine di intervenire tempestivamente qualora si ravvisi la perdita del requisito della continuità aziendale, evitare di sfociare nella situazione di crisi ed essere obbligati poi a ricorrere “senza indugio” ad uno degli strumenti previsti dal Codice. In tal caso la scelta verrà effettuata con piena discrezionalità in base alla natura e alle cause della crisi e al preminente interesse dei creditori.
Nel caso contrario in cui gli indizi della crisi vengano evidenziati e segnalati dall’organo di controllo, verrà concesso un termine entro il quale l’amministrazione dovrà attivarsi per l’adozione degli strumenti previsti con i medesimi criteri accennati. Qualora l’organo amministrativo non dovesse rispettare tali indicazioni o le azioni intraprese si dimostrano insufficienti a correggere le anomalie segnalate, l’organo di controllo dovrà attivare le procedure di allerta di cui all’art. 12 CCII provvedendo alla dovuta segnalazione all’OCRI (Organo di composizione della crisi). Trattasi in questo caso di “procedura di allerta interna” disciplinata dall’art. 14 CCII a cui si affianca “la procedura di allerta esterna” che, ai sensi dellart.15 CCII, riconosce i medesimi poteri ad alcune categorie di creditori pubblici qualificati quali L’agenzia delle Entrate, l’INPS, L’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Ecco dunque che, in uno scenario economico fortemente condizionato da un’emergenza sanitaria senza precedenti, in cui la prolungata inattività commerciale e produttiva manifesterà i suoi effetti negativi nei prossimi mesi, in un periodo in cui si renderanno necessari provvedimenti utili a supportare la liquidità aziendale fortemente compromessa, la contemporanea entrata in vigore del nuovo Codice, e l’applicazione dei relativi indicatori, potrebbe ampliare la platea di aziende da classificare “in crisi”.
La normativa in commento, secondo quanto stabilito dal “Decreto correttivo del Codice della Crisi”, approvato in Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020, ancora all’esame delle Camere, aveva già previsto la possibilità di differire alla data del 15 febbraio 2021 l’obbligo di segnalazione di cui agli art. 14 e 15 CCII, per le cosiddette “Nano Imprese” quelle imprese cioè che per due anni consecutivi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”.
In tale contesto è intervenuto successivamente il D.L. n.9 del 02/03/2020 il quale all’art.11 ha disposto che l’obbligo di segnalazione di cui agli art. 14 e 15 CCII opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 rinviando dunque l’applicazione di tali disposizioni per tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione.
Da notare comunque come il provvedimento si riferisca solo ed esclusivamente all’obbligo di segnalazione e non a tutte le altre responsabilità e che gravano sull’organo di controllo il quale, se nominato, sarà chiamato ad assolvere tutte le sue funzioni nel rispetto dell’intera normativa vigente.
RIPRODUZIONE RISERVATA – Del presente articolo ne è assolutamente vietata, sia in forma totale, sia in forma parziale, sia con frazionamento anche temporale, la riproduzione, la duplicazione, la diffusione, la divulgazione, il trasferimento e l’utilizzo con qualsiasi modalità e/o strumento con i quali tali attività possano essere effettuate.
La riproduzione può essere autorizzata in forma scritta da parte dell’autore e della società Revilaw srl e a condizione essenziale che nella riproduzione vi sia la citazione della Revilaw srl, l’indicazione della fonte (incluso il link alla pagina della Revilaw srl), della data e del nome e cognome dell’autore, se riportato.
I contenuti di questo articolo sono da intendersi, e sono intesi, soltanto a fini di semplice utilità con scopi meramente informativi in modo da fornire indicazioni, istruzioni e informazioni generiche e generali circa materie di interesse per l’uso personale del lettore e non costituiscono in alcun modo contenuti consulenziali e pareri ufficiali e professionali. Per ottenere un parere ufficiale in ordine ai temi trattati, è possibile richiedere una consulenza concordando un appuntamento telefonico con la Revilaw srl al numero di telefono +39 045 8010734 o inviando una email a info@revilaw.it .
Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.
Pubblicato il: 2020-04-07 06:58:07
Revilaw SRL
Contatti
- Sede Legale: Via XX Settembre, 9, 37129 Verona (VR)
- Tel: (+39) 045 8010734
- Mail: info@revilaw.it
- WhatsApp: (+39) 348 35 15 140
Copyright © 2020, Revilaw SRL. Tutti i diritti riservati.
P.I. 04641610235 Sede Legale: Via XX Settembre, 9 – 37129 Verona
Tel (+39) 045 8010734